DIO E’ MORTO
Qui nell’Officina mi capita spesso di revisionare vecchie cose. Questo racconto è una di queste. Ho pensato tutta la settimana a cosa pubblicare questa volta, cosa regalarvi di me e del mio lavoro; ero indeciso tra due storie, ma come si dice tra i due litiganti il terzo gode, così ho scelto di revisionare il primo racconto che ho completato, nel 2007. Lo revisionai nel 2010 per inserirlo nell’antologia inedita “Quotidiano d’ombra” e questo è il risultato finale. E’ un lavoro di quando ero ancora apprendista, ne sono orgoglioso e vi sono molto legato. Mi sono ispirato ad un brutto episodio di cronaca nera avvenuto in America alla fine degli anni novanta (la vicenda di David Parker Ray e Cindy Hendy) e alla canzone dei Nomadi. Poi io ho fatto il resto. Da grande appassionato di automobilismo ho inventato una Dream Car e chiedo pietà per le “licenze poetiche” che mi sono preso in merito; è pur sempre un’opera di fantasia il cui titolo originale era “Mercedes V Gold Edition”. E’ un racconto abbastanza lungo di cui vado fiero perché l’ho fatto uscir fuori a respirare; adesso però è tardi, il racconto ha voglia di essere letto da occhi diversi dai miei.
Buona lettura…
Dio è morto.
Michele fischiettava col gomito fuori dal finestrino; alla radio i Nomadi cantavano che Dio è morto e di venerdì santo non sembrava una casualità.
Una risata spontanea e gioiosa lo colse all’improvviso perché era il Giorno Predestinato, quello speciale, quando la sorte aiuta gli audaci.
Quella stessa mattina il colonnello Giuliacci aveva predetto pieno sole e poi, guardandolo dritto negli occhi, gli aveva ordinato di procedere. Era il giorno perfetto per compiere la Missione.
Al lavoro aveva dato tutto per non pensare troppo e rovinarsi la festa; un’attesa spasmodica lo stava consumando, se non si concentrava, avrebbe rovinato il momento vero: lo aveva costruito milioni di volte nella sua testa e ogni volta ne migliorava un aspetto. Il rischio di fallire era alto e non voleva pensarci.
Il bianco perla del suo Porche Cayenne toglieva il fiato sotto al sole che a breve avrebbe colorato i colli bolognesi prima di rosa e poi di un tramonto arancio e rosso sangue. Una Beretta sostava nel cruscotto, una Glock carica nella postina di Vuitton e un Enfield senza custodia era pronto nel bagagliaio. Un vero gioiello quel giochino del nonno: poteva sparare a due chilometri di distanza ed una volta entrato nel bersaglio, cambiava traiettoria.
Pensava a tutto questo Mik, mentre lembi d’asfalto si srotolavano sotto il ruggito del suo motore. Ogni sera proiettava un film privato nella sua testa: pieno di macelli, pozze di sangue, dolori indicibili. Lui era il signore incontrastato del mondo e nessuno poteva nulla contro di lui. Solo così poteva vivere, come non ci fosse domani.
Ah, come amava quell’Ultraviolenza senza nome e senza volto! Come in un orgasmo multiplo i suoi lembi bruciavano di desiderio, sentiva la necessità fisica di masturbarsi, ma essendo peccato avrebbe atteso di sentire il caldo appiccicarsi alle sue linde mutandine di Dolce e Gabbana senza intervenire, da Bravo Bambino timorato di Dio, come ripeteva allo sfinimento l’adorata nonna, quella Gran Puttana che si faceva ripassare da chiunque avesse un po’ di cazzo nelle mutande.
Che bella serata. Tornare stanchi e depressi dal lavoro pregustando momenti magici.
Dio è morto. Alla radio Augusto Da Olio vedeva la gente della sua generazione andare via, Michele Vecchi invece vedeva quelli della sua cadere giù. Era una sera di maggio dal profumo di rose e crisantemi.
Il vialetto d’accesso alla villetta assomigliava sempre più a un campo di prigionia per giocattoli perduti: palloni sgonfi, carri armati, camion senza ruote, pezzi da costruzione, ruote di bicicletta, automobiline senza autista. Il cimitero delle buone intenzioni.
Come una pallottola di precisione la palla da baseball colpì la portiera della macchina datata Maggio 2010 di Ivan.
“Cazzo Elvis!”
Le parole magiche che facevano dissolvere il cinquenne vandalo: era il tono della voce, quella qualità sonora che meglio di una sculacciata consentiva al Timor Panico di insinuarsi nella mente del figlio putiferio. Nel frattempo quel tappo coi peli aveva guadagnato il sedile del padrone, mugolando di gioia.
Riconosceva da lontano il motore della macchina e qualsiasi cosa stesse sgranocchiando veniva abbandonata per dedicarsi alla corsa più pazza del mondo, che terminava una volta assaltata la diligenza, senza una ragione precisa, solo per ricevere una grattata sulla testina bianca.
Quel bottone peloso lo mandava in solluchero. “Ciao Cane! Dimmi, dove si nasconde il giovane Unno … Se lo piglio! Dai, corri, corri! Andiamo a prenderlo!”
Con un balzo olimpionico il nano era fuori, mentre Ivan aveva guadagnato mezzo giardino; i sassi sotto le suole scricchiolavano come ossa di conchiglie e il tramonto stava per avvicinarsi al cielo. Dalla casa la radio avvertiva, con la voce dei Nomadi, che Dio era morto in stanze da pasticche trasformate.
La vetrata sul giardino era aperta e il vento di primavera muoveva le tende; che bella serata: nulla poteva essere più perfetto di così.
Il bar in centro era come sempre murato di gente.
L’oste era un ragazzo simpaticissimo, pieno di spirito almeno sino all’orlo. Da coma etilico.
Le cameriere, belle come la gioventù che passa e non torna più, vestivano un microgrembiule e poco altro: la sotto, che spasso! Musica soft e luci basse offrivano alla clientela relax e discrezione, il motivo per cui mezzo mondo dorato che conta si rintanava in quel boudoir; per mascherare i fantasmi segreti delle anime inquiete e tormentate da tutto quel troppo vivere.
Steve aspettava. Non poteva fare molto altro, vista la situazione.
Il Maritino di certo ora aveva trovato la strada di casa e Gioia era immersa nella parte della brava moglie che adora e serve con costanza quell’essere a due gambe.
Ah, che situazione! Ci aveva sempre riso sopra. Quando sentiva di amanti e triangoli li catalogava come errori matematici, ma ora che la geometria non euclidea stava presentando il conto non vi trovava nulla di comico. Era una cosa davvero brutta su cui fare spirito, anche se il barman ne aveva parecchio, di spirito.
Tamburellava le nocche sul tavolo; la pazienza e la sobrietà lo stavano lasciando alla mercé di immagini in 3 D niente male. I due Negroni danzavano in un circolo etilico nello stomaco di Steve e quel cervello ormai fritto ribolliva; nonostante questo riusciva ancora a pensare che non avrebbe dimenticato nulla. E’ vero che i guai hanno il brevetto da bagnini.
Il cellulare iniziò a vibrare e illuminarsi … Eccola! Gioia, che gioia!
Ma no. Era quello svampito di Franchino che chiedeva al “vecchio” dove fosse “fisicamente”. Ascoltò senza rispondere, non aveva voglia di parlare con quei coglioni che aveva per amici.
Voleva solo sentire la musica dolce che era la voce della Sua Piccola.
Onde di gelosia s’infrangevano contro il suo cuore malato d’amore, il pensiero di quella creatura classificata come umanoide che sfiorava quelle labbra lo facevano rabbrividire di rabbia. Conati di vomito lo investirono, il suo stomaco sussultava. Corsa verso la toilette: ecco, et voilà! Adesso anche i due Negroni lo avevano lasciato in pace, vuoto, solo come quel Dio morto in croce che qualcuno cantava alla radio, vicino al bancone del barista giovane e pieno di spiriti, italiani e stranieri.
Ideafix decise che era giunto il momento di scavare nuove buche in giardino, dove pisciare oppure nascondere qualcosa; raspava terra, sembrava un caterpillar lillipuziano.
A un tratto arrestò la meticolosa lavorazione per poi ricominciare un attimo dopo, con una foga non canina ma diabolica.
Lavorava alacremente e la Padrona pensò che un giocattolo perduto di Elvis fosse in procinto di ritornare alla luce in quel campo giochi dimenticato anche da Dio, ormai morto.
Abbaiava sguaiato, ma nessuno dava importanza all’evento, che avveniva in media dalle tre alle quattromila volte al giorno; l’appello canino cadde nel vuoto. Non era un giocattolo come gli altri, Ideafix se lo sentiva dentro quel cervellino.
Ma si sa, can che abbaia, non morde.
Steve, seduto al bar, guardava inebetito il cellulare muto e con la batteria quasi scarica.
Decise di prendere un altro beverone alcolico: la cameriera mora portò l’ennesimo Negroni.
Quando puoi farti del male, fallo, punto e basta. La testa gli girava in un valzer velocissimo, lo stomaco bruciava mentre i pensieri non volevano smettere di rincorrersi, voleva solo dimenticare tutto. Ma per ora non era possibile. Non poteva farlo perché c’era dentro fino al collo. Bere per dimenticare, bere per non stare male.
Come sono strane le cose a volte: vite lontane e differenti tra loro che intersecano traiettorie nuove, anche solo per pochi istanti, per poi ritornare distrattamente sotto forma di salvagente nei momenti più impensati.
Gioia aveva sfiorato la vita sregolata di Steve così, per puro caso. Era la cassiera della filiale Carisbo dove aveva aperto un conto: l’aveva conosciuta mentre versava un assegno.
Poi, in un banale giorno di pioggia l’aveva amata con un solo sguardo. Non era più riuscita a uscire da quella sua vita solitaria, lui non gliel’aveva permesso.
Si era appoggiata al suo cuore, leggera, in silenzio, per non disturbare perché era così per lei, la normalità. Aveva una voce delicata, sussultando e fremendo di calore diceva cose, ma ne pensava altre.
Incredibile a dirsi; quella minuta impiegata che lo aveva aiutato era l’Amore.
Quell’amore che non dorme mai, che sogna mondi nuovi, proprio come il gelato di panna che si soglie nelle mani della ragazzetta durante lo spot alla televisione.
Piccolo Amore, eterno finché dura.
Elvis, sbucando da sotto il tavolo, disse con un abbraccio che sapeva di aver fatto un casino, ma come il bottone di pelo quel marmocchio era per Ivan il lato migliore del cuore: quanto lo aveva voluto, desiderato e sognato. Credeva che non sarebbe arrivato mai, ma la sorte gli aveva dato una piccola peste.
Chiese solennemente scusa con un bacio e nel giro di pochi millesimi di secondo trovò un sistema innovativo di sfasciare la casa.
Scorrazzando col triciclo al piano di sopra trovò la porta dello studio aperto, invitante come la granita di menta a Luglio. Non entrare sarebbe stato un peccato, Papy aveva dimenticato di chiudere la stanza!
Che posto! Porte, porticine e cassetti da scassinare! Il monitor acceso del computer emetteva un bagliore sinistro; era l’unica fonte luminosa della stanza, ma tanto bastava a Occhio di Falco per capire dove produrre morte e distruzione. Sul divano una strana forma riposava; indumenti del padre accovacciati come mostri marini, resi innocui dalla lama di luce che filtrava dalla porta. L’unico pericolo reale consisteva nell’orda barbarica concentrata in cinque anni d’argento vivo.
Un bellissimo cassetto era aperto nella scrivania, senza sforzo Elvis v’introdusse la manina per esplorarne il contenuto e … fantasmagorico! C’era davvero di tutto: strane forme lisce, ruvide, fredde e simili alle armi che nonno Saverio tante volte gli aveva permesso di soppesare, quelle della sua collezione di Smith & Wesson. Con quelle mani da delinquente in erba capì che la roba lì dentro era davvero strana, decise che era uno scasso facile e così lo spalancò del tutto, rischiando di rovinarlo al suolo.
Non capiva che roba fosse, Boh! Strani oggetti di forma tentacolare, colori sgargianti oppure trasparenti, come i soprammobili di mamma; strane cose liquide o in forme simili alla sua plastilina.
Perse interesse in fretta, richiuse a fatica e saltò a bordo del suo triciclo chopper, perché conosceva a memoria la favola di Barbablù, la sua prediletta e mamma gli ricordava sempre che poteva andare ovunque ma non nella stanza di papy.
Se ne andò come era venuto. Lontano dagli occhi.
“No ce la faccio più Gionny, davvero, la situazione mi è sfuggita di mano … Credo che se andassi via per Mik sarebbe tutto più agevole. Le cose potrebbero andare a posto. Non credevo che potessi mai arrivare a questo, ma stavolta non c’è ritorno, purtroppo”.
Anna, triste e disperata, diceva quelle parole con la bocca, non col cuore.
L’amore per il suo Michele le bruciava l’anima; quella botola in cantina, sospesa su neri golfi della pazzia l’aveva gettata in una totale disperazione. A quella ci si aggrappa quando si vuol mandare il cervello in vacanza, ma purtroppo la solidità del mondo reale lo impedisce.
“Anna, cerca di ragionare! Non so cosa hai visto, ma almeno aspetta ad andare via, aspetta che venga lì, per piacere!”.
“Non so, vieni pure … E’ pur sempre tuo fratello, non credo possa insospettirsi vedendoti! E poi ho bisogno di compagnia. Porta anche Carmela, è giusto che vediate entrambi quelle cose la sotto …”
“Va bene, a tra poco”.
“Grazie ragazzi, davvero, grazie …” Anna riagganciò il ricevitore e si sedette ad aspettare qualcosa che non conosceva ancora.
La collina era semplicemente Perfetta.
Parcheggiato il Cayenne nella piazzola sottostante per evitare testimoni curiosi, Michele iniziò la salita da dietro per essere certo di non essere visto una volta giunto nello spiazzo predestinato, dispose pistole e fucile accanto a se come macabri compagni di quel pic nic demoniaco nei recessi dell’inferno e attese. Aveva abbastanza cartucce per divertirsi, ma non sarebbero state sprecate inutilmente: avrebbe fatto troppo rumore per nulla.
Si allenava al poligono due pomeriggi a settimana, prima di andare in palestra. Michele aveva il culto della forma fisica, della Perfezione ad ogni costo e tutti i giorni dava il massimo, fino allo sfinimento.
Era un perfezionista maniacale dedito alla più scrupolosa cura di se, adorava la sua immagine riflessa nello specchio e non ne faceva mistero.
Credeva ciecamente che sarebbe arrivato dove voleva solo con le sue forze, anche perché la sua famiglia non era stata sempre presente. Anzi, era cresciuto con suo fratello Jonathan e i nonni; aveva imparato presto che la vita non è sempre una cosa meravigliosa, nonostante il conto in banca. Suo padre gli ripeteva continuamente che doveva essere felice per tutti i soldi che avrebbe ereditato, ma non lo era.
Odiava quelle persone e imparò ad approfittarsi di loro. Solo il fratello era parte del suo cuore, l’unica persona, a parte Anna, che avesse mai amato. Anche lui sapeva farlo, ma lo faceva a modo suo.
Aveva aperto lo sgabello portatile e si era sistemato comodamente nel punto giusto: dalla collina vedeva bene la strada e allo stesso tempo la vegetazione lo nascondeva alla vista.
Poteva rimanere lì per giorni senza che nessuno se ne accorgesse. Aveva svolto diversi sopralluoghi dopolavoristici e alla fine decise per quel declivio ben protetto, da lì lo Splendido Festival di Morte e Distruzione poteva avere inizio.
Quanto tempo, prima di avere il giorno giusto.
Ore e ore spese per fare calcoli, studiare, capire. Cercare il posto adatto, libero e senza nulla attorno ma che allo stesso tempo fosse raggiungibile. Un luogo che potesse essere trovato e al tempo stesso nascosto a tutti. Dove le macchine transitassero senza sostare, senza intralciare.
Dopo mesi di duro lavoro e ricerca aveva trovato per caso il posto ideale da pic nic, quello perfetto per dare il via al suo gioco più grosso e divertente.
Prese il cellulare e avvisò Anna che quella sera avrebbe tardato un po’: si sarebbe intrattenuto con amici per un aperitivo ed una pizza al nuovo ristorante del centro commerciale, nulla di speciale. Sarebbe rientrato intorno mezzanotte.
Anna rispose che non era un problema, gli faceva bene stare un po’ con gli amici.
Prima l’aperitivo, poi una bella abbuffata.
Già, prima un aperitivo.
Poi, una fantastica abbuffata di carne. Alla griglia.
Anna non si agitò, non pensò a nulla durante quella telefonata col marito, non riusciva e non voleva pensare perché ne aveva già troppi, di pensieri. Non poteva ragionare lucidamente e rispose a Michele meccanicamente, senza sentimento e si augurò che lui non se ne fosse accorto.
Aveva mandato in pensione il raziocinio, voleva solo trovare il modo di scappare da quello che fino a poche ore prima era stato il suo Nido d’Amore. Riappese il telefono e si sedette tra Jonathan e Carmela.
Una paura strisciante le sfiorava con dita gelide la spina dorsale, era vittima del lupo mannaro che si era impadronito delle loro Impareggiabili Esistenze. Aveva dentro il cuore una pietra di granito nero che spingeva verso il basso, verso un luogo tetro di solitario abbandono.
I pensieri normali, quelli che si fanno alla luce del sole, dovevano inesorabilmente morire al cospetto di quel buio morboso nascosto dalla botola: non poteva essere altrimenti. Un buio messo lì per celare alle menti sane il contenuto di quel’’antro senza nome, per impedire alla luce del sole di morire davanti allo spettacolo della follia.
Steve ordinò alla bionda dal culo sodo l’Ennesimo Negroni del pomeriggio, lo centellinò con cura mentre osservava la fauna locale in attesa.
La piazza della cittadina risplendeva di un tramonto rosa shopping di ragazze soddisfatte per le scarpe nuove, primavera al profumo di viole e la gioventù scatenata nelle gambe nude, gelati sgocciolanti come neve al sole. Si liquefaceva solo al pensiero.
Vedeva l’ombra della sua Gioia all’interno della stanza da letto, sopra la piazza; si muoveva come tormentata da un fantasma mostruoso. Forse stava discutendo con l’umanoide che aveva sposato due anni prima e che già tradiva col primo arrivato.
Sentiva un ruggito in lontananza, o almeno un suono simile; sentiva che Tutto stava per succedere. Di certo stava annunciando che le valige sul pianerottolo erano sue, che sarebbe andata via, che basta, non lo amava più … Steve sorrideva tra se, allegro ed innamorato come uno scolaro di terza media.
La fauna nel locale lo affascinava: tutta quella Bella Gente che beveva, rideva, nascondeva nel mistero i suoi misfatti era divertente. Come quando giocava a calcio e frequentava i posti trendy, quelli dove la gente lasciava le vecchie cinquecentomila lire a profusione e lui si divertiva da matti tra alcol, donne e fama.
Sotto la finestra della sua Gioia una ragazzina piangeva aggrappata al cellulare. Il tono e i modi erano quelli di chi sta per essere abbandonata. S’immaginava quel suo giovane amore dall’altra parte che la stava lasciando proprio in quel momento. Gli sembrava un modo vigliacco di comportarsi e il Negroni aiutava a crederlo con più vigore; dava l’impressione di avere troppa fretta di sbarazzarsi, come fosse un pacco non richiesto, di qualcuno che fino a poco prima riempiva le notti e i pensieri. Ma l’amore è fatto così, o almeno ogni tanto assume questa forma.
A volte diventa un chiodo che graffia le pareti del cuore, arrugginisce le parti vitali del nostro essere e uccide quel pezzo di mondo su cui facevamo affidamento. L’amore è un veleno sottile, una lametta che si pianta nei polsi a fondo, fino al manico. Inquina sino a rendere una landa inabitabile il nostro essere. Ammazza la consapevolezza del futuro, spezza il cuore come se fosse di vetro e annulla tutto quello che eravamo sino a poco prima, o che credevamo di essere. Se l’amore muore allora forse, non è mai esistito. Perché l’amore non muore, diventa altro, o di qualcun altro, ma non finisce col termine delle nostre credenze, semplicemente si trasferisce da un’altra parte. L’amore, quello vero, sta dentro il cuore che lo custodisce come seta preziosa lontano dalla polvere, dal freddo e dalle tempeste che volte arrivano.
Ma si sa: non si può amare per sempre.
Anna e Michele si sono sposati molto giovani: due ricchi rampolli che si accoppiano come i cavalli pregiati delle scuderie famose.
Due settimane prima del venerdì santo avevano festeggiato il loro decimo anniversario. Entrambi trentenni di successo, soprattutto lui, a capo dell’azienda di famiglia. Vivevano spensieratamente tra feste e lussi sfrenati, amavano la bella vita, ma non erano degli sconsiderati: preferivano rimanere fuori da certe cose che urtavano contro la loro rigida educazione cattolica.
Michele trovava ripugnante tutto quel “giocare col fuoco”, come lo definiva lui e Anna sapeva di poter contare nella frase pronunciata sull’altare: “In salute e in malattia finché morte non vi separi”. La fiducia era reciproca, almeno così doveva essere. Erano solo persone normali, senza vizi, senza stranezze. Lei ci aveva creduto ciecamente almeno sino a quella mattina, quando le cose hanno cambiato forma, aspetto e colore. Quello che aveva progettato da bambina era finito nel buio di una fredda cella senza nome e senza luce.
Quella botola in cantina aveva fatto saltare in aria tutto il meccanismo di chiusura della gabbia dorata che si erano costruiti per proteggere la loro vita Fantastica dalle aggressioni esterne.
Un sistema antifurto contro quel mondo marcio che loro non volevano nemmeno vedere.
Quel giorno Anna aveva pensato di fare una sorpresa a Michele facendo restaurare il vecchio scrittoio di suo nonno Rodolfo. Era scesa in cantina per capire quanto lavoro ci sarebbe voluto per tirarlo su da lì assieme al cognato Jonathan quando inciampò in un tappeto logoro che non si ricordava fosse in quell’angolo buio, cadendo sopra qualcosa di cui era all’oscuro.
Il caso: quel sistema di leggi che ti fa cadere dentro lo specchio rotto del destino. Si trovò con la faccia sporca di terra e vide un riquadro mal celato che portava direttamente dentro un Maelstrom di terrore puro. Sotto c’era una ripida scala malandata, non illuminata, che conduceva in un orrendo e puzzolente stanzino muffoso. Decise di aprire quella botola.
Appena gli occhi si abituarono al buio iniziò a vedere cose di cui ignorava l’esistenza nel mondo reale, cose che credeva esistessero solo in certi filmacci che lei non aveva mai voluto guardare.
Era una specie di caverna, o meglio, una di quelle cantine che si trovano nelle vecchie case. Credeva che del vecchio palazzo signorile su cui sorgeva la loro bellissima casa ultramoderna non vi fosse nessuna traccia, ma ora sapeva di sbagliarsi. Alle pareti laterali vi erano delle vecchie mensole sghembe, e sui ripiani polverosi c’era ogni sorta di strumento di tortura, soprattutto, almeno a prima vista, sessuale.
Fruste e cappucci, falli artificiali e tanto altro che il buio gentilmente nascondeva alla vista.
Aveva una torcia, trovata su una di quelle brutte mensole, ma serviva a poco, per fortuna.
Quel luogo le faceva venire in mente il film con Jhonny Depp su Jack lo squartatore. Brividi gelidi le percorrevano come un serpente tutto il corpo.
In un angolo vide un vecchio letto di ferro battuto, malandato e macchiato di sangue, le ricordava le antiche vestigia del palazzo che un tempo lì sorgeva, una specie di ricordino, di quelli che potresti trovare a casa di Freddie Kruger; una porta blindata dipinta di nero era il pugno nello stomaco del raziocinio e chiudeva un mondo che forse Anna non avrebbe dovuto conoscere. La chiave, con grande arroganza era appesa alla maniglia: una specie d’invito, forse, o una sciocca dimenticanza da parte di suo marito. Con un grido muto sul viso, stampato come una maschera del teatro Kabuki, Anna aprì quel divisorio tra la sanità e la follia, decidendo di chiudere il suo cervello a chiave per non finire tra mura imbottite.
Non sapeva cosa potesse esserci di peggio, ma lo capì una volta dentro.
Delle catene rugginose penzolavano dal muro, erano coperte di sangue rappreso, più scuro e più chiaro. Fu un lampo soltanto però, perché una luce fortissima si era accesa appena aperta la porta. Appena riavutasi dallo shock vide che alcuni strumenti chirurgici erano posizionati come un set da ferrista accanto ad un lettino da sala operatoria e rilucevano con cupa follia sotto a quella luce fortissima e bianca come la morte. C’erano delle mensole con parti anatomiche in formalina. Pensò a Barbablù, la sua fiaba preferita, a quando da bambina supplicava la tata inglese perché la raccontasse un’altra volta ancora, col faccino nascosto dalla coperta.
Avrebbe dato tutto il suo patrimonio in quel momento per riavere la sua copertina e nascondere la faccia ormai adulta. In quel momento era come se avesse solo pochi minuti di vita, come se fosse morta e rinata dentro il sogno folle di un malato sadico di mente. La ragione se n’era andata in frantumi sotto il peso della follia.
Avrebbe voluto formulare un incantesimo di sparizione e finire sull’isola che non c’è; un’isola che ora non esiste più, ma che era la sua casa fino a qualche istante prima.
Senza rendersene conto permise alla pesante porta di chiudersi piombandola nel buio più nero dell’universo, dentro ad un terrore senza nome ne volto e non poté fare altro che svenire. Un grido lontano le saliva dal cuore, ma risuonò solo nella sua testa, poi tutto divenne nero anche lì e cadde giù. Non sapeva per quanto tempo fosse rimasta nella sua incoscienza, ma quando riaprì gli occhi, la luce accecante era nuovamente accesa. Per un attimo pensò di essere stata scoperta, di essere al capolinea in attesa di una rapida morte. Questo pensiero la rallegrò: a quel punto le sembrava l’unica soluzione plausibile. Su mensole di fortuna c’erano ogni sorta di gadget sessuale apparentemente artigianale e una collezione di riviste porno e fetish. Sporcizia, puzza di vomito acido e urina, feci rapprese, e un’infinità di corde, catene e lacci penzolanti dal soffitto come cadaveri d’impiccati. Se l’inferno esiste davvero, quella cantina doveva esserne la riproduzione fedele.
In superficie, alla luce colorata del tramonto, tutto sembrava senza senso. Si sentiva come se avesse visitato il set cinematografico di un episodio di CSI e non il suo scantinato. Le ricordava quel servizio di Studio Aperto su quella coppia di debosciati americani che erano stati arrestati per sevizie su alcune prostitute. Seduta sul divano, con una tazza di the e i suoi cognati ogni cosa pareva fredda e razionale, tutto era tornato in ordine perché Anna era così: logica e calcolatrice. Tutto aveva una spiegazione. Quello che stava la sotto ora non aveva importanza.
Doveva capire se stava dormendo, se era nel mondo vero e tangibile oppure in un incubo dove i morti sono morti e le botole si spalancano sull’abisso.
Gionny e Carmela, seduti sul divano accanto a lei, tacevano; guardando la sera arrivare dall’ altro capo della terra.
Ivan si era costruito la sua fortuna tutto da solo.
Era uscito da scuola con tanti sogni e pochi soldi in tasca, senza prospettive concrete se non la sua faccia da bravo ragazzo pulito. Il suo primo lavoro fu come cassiere alla Coop del quartiere Barca. Poi, proprio lì conobbe l’amore: Stefania. Pochi anni dopo divenne sua moglie, e un po’ di tempo dopo la madre di Elvis.
Nel frattempo, con i risparmi, si era comprato la prima macchina fotografica poi la camera oscura. Sfonda, letteralmente, come fotografo di moda: tutti lo cercano e diventa un’icona nel bolognese, poi nel resto d’Italia. Tutti lo vogliono e la sua agenzia nel giro di pochissimo tempo diventa la più famosa, solo la Corona’s poteva fare concorrenza.
Con un fatturato medio annuo di tre milioni di euro Ivan era ricco, famoso e ancora giovane. Aveva una bellissima moglie che lo amava e si fidava di lui. Ivan aveva tutto, troppo di tutto e ne era consapevole: sentiva, a volte, che le cose erano troppo perfette.
Gli faceva paura tutta quella perfezione perché era irreale, scontata, incredibile.
Era scaltro, Ivan. Temeva che i nemici, gli invidiosi, prima o poi avrebbero presentato il conto.
Quel pomeriggio si era sdraiato sul divano per schiacciare un riposino mentre Elvis usciva dallo studio del padre senza farsi scoprire; aveva compiuto un piccolo furto ma sapeva come rimettere tutto in ordine una volta esaminato il contenuto delle foto che aveva “preso in prestito”.
Erano delle fotografie strane del suo papà. Ne aveva viste tante fatte da lui ma nessuna assieme al suo amico. Erano nudi e si baciavano. Facevano anche altro, ma i cinque anni sulle sue spalle non gli permettevano di capire gli oscuri giochi paterni nella macchina bianca dell’amico strano e in quella stanza ricolma di cose che lui non aveva mai visto, se non poco prima nel cassetto segreto della scrivania.
Adesso era nella sua cameretta, pian piano le ripose sotto il cuscino e se ne andò, verso l’infinito e oltre, a far danni. Decise che avrebbe giocato un po’ ai pirati, correndo giù dalle scale e dondolando appeso all’albero in giardino. Che bella la vita quando si hanno cinque anni e l’argento vivo addosso, quando tutto quello che ci succede è un bel gioco, quando la gioia è autentica e non filtrata attraverso la cattiveria e il sospetto. Quando le persone non hanno segreti da condividere perché sono troppo alte per noi.
Il cellulare trillò nel silenzio della casa e la voce profonda e impastata di sonno del padre rispondeva con cattiveria a qualcuno.
Fece appena in tempo a mandare un bacio all’indirizzo del padre che stava andando via, concitato e frettoloso. Ivan lo baciò sulla guancia dicendogli con lo sguardo quanto lo amava. Imboccò il vialetto d’accesso a tutta velocità, sgommando con i pneumatici nuovi sull’asfalto.
“Ragiona, cazzo! Ma ci sei, ci fai, o cosa?! Ti rendi conto di quello che stai sbrodolando da quella fogna che chiami bocca? Terra chiama Michele Vecchi, ci sei, MV? Ragiona, che il cervello ti dovrebbe ancora funzionare … O sei così sbiellato da non capire che non ne voglio più mezza di tutta ‘sta merda? Che cosa vuol dire: Ci sei dentro fino al culo! No, no mio caro, vai tranquillo che io me ne esco quando ne ho voglia … No bello mio, ho detto che ho chiuso con te e la tua cantina del cazzo, ok?”
Finalmente il telefono squillò. La voce era esattamente quella che voleva sentire.
Fiducioso ascoltò tutto quello che la sua Gioia aveva da dire, senza interromperla, come aveva chiesto. Ebbe come l’impressione di nuotare, di sentire e vedere il mondo come da molti chilometri sotto l’oceano Atlantico. Stava annegando. L’aria nel respiratore era ormai finita, la vita scivolava lontano da lui. Fu come prendere una fucilata allo stomaco, il rosa del tramonto divenne rosso sangue, moriva la giornata. Con lei, moriva la speranza.
Gioia da dietro le tende gli diceva addio. Ne scorgeva la sagoma, percepiva i movimenti nervosi di chi sta dicendo delle brutte cose, ma non vide il suo bel viso. Voleva sapere se era rigato da lacrime o da indifferenza. Non sarebbe partita con lui, il marito era ancora al primo posto e non se la sentiva di lasciarlo solo: lo amava ancora, in fondo. E lui? Che cosa doveva dire, lui?
Non soffriva forse? Era condannato a rimanere solo e senza amore e continuare a girare per il mondo come un’anima penosa e solitaria. Steve non sentiva di possedere quell’egoismo che gli veniva rimproverato, sentiva solo il cuore spezzarsi, cadere giù, nel buio dello stomaco.
Si rese conto di tutta l’ingenuità da innamorato che ci aveva messo, di quanto fosse stato stupido a credere nell’impossibile.
Comprese quanto Gioia in fondo fosse codarda, di come avesse idealizzato un sogno di vita irrealizzabile. Sentiva il peso degli anni, dei bei tempi andati, di quando le ragazze gli saltavano addosso per cercare di sposarlo, di avere dei figli con lui; si rese conto solo adesso che stava ricevendo lo stesso trattamento che lui aveva sempre riservato a tutte quelle ragazze negli anni.
Gli sembrava che la Legge del Contrappasso gli fosse rovinata addosso con tutta la coda.
Pagò il conto e barcollando si avviò verso un dove non ancora stabilito. Passò accanto alla ragazzina che piangeva attaccata a uno squillo muto ed ebbe voglia di abbracciarla, di stringerla per consolare quel dolore cieco e insegnarle che nel male purtroppo non si è mai soli.
Andò all’automobile e imboccò la provinciale diretto in nessun luogo.
La Collina della Festa guardava la strada provinciale e il diabolico piano di Michele sarebbe riuscito, se Ivan lo avesse raggiunto passando proprio da lì al momento desiderato.
Doveva solo farlo parlare, tenerlo aggrappato a quella cella nell’etere il tempo necessario per trovarlo inquadrato nel mirino termico adattato sul vecchio fucile del nonno, quello che usava per giocare al tiro al bersaglio con i nazisti sulla Linea Gotica tra Badolo e le Lagune, quello che avrebbe ridotto a brandelli la testa del Traditore.
Non poteva interrompere il loro “sodalizio artistico”, finire così quella relazione anima e corpo che li legava indissolubilmente. Michele si divertiva con lui. E se Ivan interrompeva il divertimento, lui avrebbe interrotto la sua vita. Per sempre.
La strada si srotolava sotto la macchina nuova di Ivan, la Rabbia montava dentro di lui, sentiva che tutto quello che aveva costruito stava per dissolversi come un castello di carte, che il famoso giorno in cui tutto sarebbe finito era arrivato; voleva solo correre veloce alla collina per far ragionare Michele, per ucciderlo, se necessario. Stava parlando con un folle da manicomio, cercava di farlo ragionare, come si fa coi bambini quando fanno i capricci e non vogliono andare a letto; cercava di trovare l’interruttore della normalità per riportare sulla terra quello che una volta era stato il suo migliore amico. Sin dai tempi della scuola avevano fatto baldoria assieme, si erano ubriacati, avevano avuto le stesse ragazze e si erano sempre detti tutto quanto. Adesso era al telefono col fantasma di un Natale malato e senza speranza. Aveva paura perché la deriva gli stava togliendo ossigeno.
Una Mercedes uguale alla sua, avanti un centinaio di metri, segnava il passo verso la follia. C’erano solo loro per strada e quindi Ivan aveva tutto l’asfalto che voleva per correre incontro a un destino incerto e pericoloso.
Gionny, risalito alla luce del mondo dopo la visita dentro la botola, si sentiva più vecchio di vent’anni. Carmela era fuggita molto prima, presa dal ribrezzo.
Non voleva credere che il suo adorato fratello fosse affetto dalla sindrome del dottor Jekill. Amava quel ragazzo come nessun altro al mondo: erano cresciuti assieme, soli, in un meraviglioso rifugio dorato mentre i loro genitori erano troppo occupati a fabbricare soldi. Erano sempre stati assieme per aiutarsi e sostenersi e adesso era caduto dentro ad un gorgo di morte e pazzia; non riusciva a crederci.
Anna vedeva la vita scorrere al rallentatore. Una patina di ricordi lontani si scioglieva, un cancro maligno stava evolvendo e lo avrebbe fatto per ere infinite, dietro a quegli occhi azzurri che erano stati di suo marito, dentro quelle iridi fino ad un attimo prima così vicine e familiari, piene di serena fiducia in un futuro assieme.
Gionny si chiedeva come la mente umana potesse concepire tali orrori mantenendo comunque una sorta di normale atteggiamento nei confronti del mondo intero.
Come poteva, senza sforzo, la follia nascondersi dietro all’apparenza fatta d’inutile vuoto, dietro alla consapevolezza assoluta della vita, dietro ad un quotidiano d’ombra. Vivere la vita in bilico, tra Mondo Civile e Orrore Totale, diviso nella più completa assenza di emozioni per quello che faceva: Michele era tutto questo. Un perfetto terribile sconosciuto senza nome.
Anna non poteva più stare in quella casa; si decise a fare le valige perché non avrebbe mai più potuto dormire nella sua stanza, sopra a tutta quella morte.
L’Ignoranza aveva protetto le loro vite ma ora tutto era caduto, fuori dal blu dentro il nero.
Non sapeva come ma aveva chiamato la polizia subito dopo aver riagganciato con il cognato. Non si ricordava di averlo fatto, non sapeva che cosa avesse detto a un incredulo centralinista che le domandava l’indirizzo.
Sarebbe rimasta da loro per un po’. Sicuramente la polizia non le avrebbe permesso di tornare lì per molto tempo. Uscendo guardò il via vai delle forze dell’ordine come in un film hollywoodiano e si mise a piangere silenziosa. Non era certa che fosse tutto vero: le tute bianche dei Ris, le auto della polizia e il tramonto rosso sangue che la stava accecando. Il mondo ora sembrava davvero un set cinematografico, un luogo inesistente dentro la sua testa.
Un poliziotto corse fuori vomitando la merenda mentre la scientifica portava dentro altri strumenti per le rilevazioni. Quel vomito era reale e non di plastica.
Anna si girò per l’ultima volta, come a salutare quel sogno che non sarebbe mai stato più lo stesso; quel meraviglioso nascondiglio dorato che nelle fondamenta celava un girone più infernale degli altri. Camminando curva, vecchia di duecento anni, salì in macchina. Una lacrima solitaria segnava quel viso che non le apparteneva più.
Si vergognava molto del pensiero che stava facendo, non era da lui, ma la realtà lo aveva portato su quelle strade senza nome.
Steve stava meditando di togliersi la vita, di morire per non dover più pensare a niente.
Correva come a Le Mans nella provinciale stranamente vuota, come se un richiamo magico avesse deviato tutti i veicoli per evitare lo schianto senza ritorno che tragicamente cercava.
Andava verso qualcosa di cui non conosceva il nome, un futuro senza Gioia e senza gioia, senza l’amore che lo teneva in vita, col respiratore ormai esaurito.
Correva e pensava che la vita l’aveva stancato: non c’era più molto da fare su questa terra visto che la ragione della sua esistenza lo aveva lasciato tramite un telefonino; senza pensarci molto su aprì il finestrino e lanciò nel vuoto quel giocattolo dalla batteria scarica. Un I Phone 4 con due settimane di vita, una in più della sua bellissima Mercedes.
Quella subdola codarda non era nemmeno scesa giù per parlare, Gioia sapeva bene che Steve era lì, lo aveva scelto lei il posto, sarebbero partiti senza lasciar tracce e tanti saluti alla compagnia.
Pochissime auto correvano in entrambe le direzioni in quella bella serata di Maggio, dirette in qualche luogo e con uno scopo ben preciso: un pubblico modesto per schiantarsi contro un palo e finire la triste storia di un amore disastrato. Ebbe una specie di visione: una Mercedes uguale alla sua cercava di guadagnare terreno. Il concessionario Canti gli aveva confidato che dalla Germania sarebbero arrivate a Bologna solo due Gold per tutto l’anno. Fino a gennaio 2012 non ne sarebbero arrivate altre.
La fatalità della vita: decidere di distruggere una macchinetta da quattrocentosessantamila euro avendo alle spalle la gemella e sapendo che così ne rimarrà solo una. Il diavolo è nei dettagli. Com’è fatidica, a volte, la morte. La Nostra Signora decide tempi e modi lasciandoci solo l’illusione del controllo, proprio come farebbe una bella donna insoddisfatta.
Ivan, accecato dal furore, vide finalmente la gemella della sua bellezza su ruote; che coincidenza! Canti gli aveva detto con una punta di malcelato orgoglio che solo un’altra persona aveva acquistato quel particolare modello e che fino a Gennaio 2012 non ne avrebbero mandate altre in tutta Italia.
La Mercedes Classe V Gold Edition era un piccolo gioiello di tecnologia e bellezza che poteva fare da zero a cento in tre secondi e quattro come un giocattolo per circuiti. Aveva la scocca in una lega speciale di carbonio e alluminio e il motore era stato sviluppato all’AMG, sulla base di quello della McLaren F1. Le portiere ad ali di gabbiano convertibili in apertura standard invece erano state progettate ripensando la vecchia 300 SL. Decise, mentre parlava con quel folle di Michele, che avrebbe sfidato tutta quella bellezza in una gara di velocità, voleva studiarla dal di fuori. Era elettrico come un temporale estivo e faceva ormai le scintille, la Rabbia era così tanta che credeva di esplodere in mille pezzi, doveva far qualcosa per sfogarsi.
Nel buio dello studio Elvis aveva lasciato inconsapevolmente traccia del suo passaggio.
Qualcosa dal cassetto della scrivania era caduto. Una cosa segreta, che nessuno mai avrebbe dovuto trovare senza il permesso del rispettivo proprietario.
La mamma, come sempre, raccoglieva quello che il piccolo seminava per casa; si era accorta del raid nello studio e sorridendo tra se cercò di risistemare i danni. Vide un piccolo album fotografico e lo raccolse. Lo rimise nel cassetto e lo richiuse, prima però la curiosità decise di uccidere il gatto.
Il suo sorriso si liquefece sul volto, dilaniato da quei rettangoli di carta lucida. Non poteva nemmeno sognarle in preda ad un acido quelle cose. Non potevano essere vere, non dovevano.
Tutta la fiaba della Vita Fantasmagorica uccisa da quelle immagini lucide e sgranate, dentro un mondo dove il marito dei sogni assumeva le sembianze di un demone cattivissimo.
Ivan e il suo amico Michele, l’amico per la pelle. Si baciavano nel Cayenne e in una strana stanza simile a una sala operatoria. Le foto mostravano rapporti sessuali tra loro e con gente inequivocabilmente morta o gravemente ferita. Represse un conato di vomito e il desiderio di urlare perché l’Allegra Canaglia, con sguardo colpevole, aveva visto mamma davanti ai suoi misfatti. Non lo guardò nemmeno, lo attraversò come se fosse un ologramma e si dileguò da quella stanza. Scappò giù per cercare il cellulare e capire dal marito che cosa fossero quelle foto. Voleva sapere se era dinanzi ad una caduta verticale o a un’installazione d’arte moderna.
“Cazzo Ivan! Rispondi!”
La canna del fucile era saldamente puntata verso la strada, Michele ne controllava il passaggio come un governatore, e nel frattempo parlava col suo Amico: “ E dai, Ivan cerca di ragionare…“.
“No carino, non sono malato, non sono matto, non sono da legare!!”
“Cazzo, non puoi tradirmi così. Ricorda: se mi tradisci, ti fotti. Ci sei dentro quanto me.”
Ideafix continuava a dissotterrare l’oggetto misterioso, ma pareva troppo impegnativo per lui. La fatica lo opprimeva, ma con convinzione continuò nel lavoro, come una ruspa in miniatura.
L’oggetto si stava disincagliando dalla terra e nel cervello del canide qualcosa prendeva forma, un credere, un obbedire e un combattere per un osso o una vecchia palla.
Il duro lavoro ricompensa il can che suda.
Ivan col balzo felino del suo motore tiratissimo raggiunse la gemella. Tre secondi e settantacinque per passare da cento a duecentodieci, non male, e bravi tedeschi.
Gli era a fianco. Viaggiavano cofano a cofano verso la follia che aveva deciso di unire i loro destini. Al mondo dei vivi o dei morti: ecco a cosa portava quella lotta contro il mondo che avevano ingaggiato inconsapevolmente assieme.
Finalmente Steve vide il proiettile dorato e comprese che avrebbe potuto trovare una via d’uscita a quella strettoia, in quel pomeriggio della sua vita.
Avrebbe fracassato i sogni del mondo intero, morendo solo e senza amore dentro quel gioiello tedesco, annullando il destino di quell’uomo incolpevole. Il destino correva parallelo, proiettili d’oro verso un nulla senza più sogni e incubi di altri.
Michele vide nel mirino termico il giocattolo dorato dell’Amico.
Chiuse gli occhi nell’attimo esatto in cui sparò.
La fucilata fu Perfetta.
Quello che accadde dopo è frutto di un sogno folle, o forse del fatto che un venerdì santo così alto non si era mai visto. Al fatto che anche Dio era morto sul serio.
Aprendo gli occhi ci vide doppio. Due Mercedes stavano danzando un ballo mortale conclusosi troppo in fretta dentro il profondo fosso ai bordi della strada.
Ci era riuscito, e che spettacolo! Due al prezzo di uno! Nemmeno nei recessi più selvaggi della sua mente aveva sperato in un epilogo così. Non aveva importanza chi fosse l’altro: Il destino non ha memoria, la morte nemmeno.
Un fumo denso si sviluppò dalle due vetture e il botto fu tremendo. Fiamme altissime tremavano sopra il radiatore di una delle due e una risata spontanea ed esplosiva inondava l’aria attorno al crudele cecchino. Senza pietà, senza ricordi, né presente o futuro. Ora era libero, o almeno così credeva. Non sapeva ancora che il destino ha memoria. Era a casa sua ad aspettarlo, per condurlo innanzi all’orrore, quello vero nascosto in cantina. Senza Anna a tenergli la mano.
Finalmente il lavoro canino diede i suoi frutti e Ideafix mugolò di piacere.
Portò l’oggetto alla padrona in salotto, come faceva tutte le volte, anche diecimila al giorno. Stefania prendeva e gettava l’oggetto nella spazzatura, un gesto meccanico e consapevole.
Era fiducioso e pieno di gioia, avrebbe avuto la giusta ricompensa questa volta …
Mentre morivano Ivan e Steve si guardarono dicendosi senza parole che la morte ha memoria e che il destino è cieco, sordo e figlio di puttana.
Il proiettile sfondò il vetro dell’auto di Ivan trapassandogli il cervello, ma in quel diabolico istante fu come se il proiettile avesse preso vita; non si conficcò nella sua testa, sfondò il vetro lato passeggero e andò a terminare il suo diabolico compito conficcandosi nella testa dell’innamorato deluso che era indietro di una spanna. Quella spanna fatale che decide per tutti.
Si era conficcato nel bell’occhio sinistro dell’ex calciatore.
Mentre moriva Ivan non pensò più a niente.
Steve pensò che sarebbe stato comico, durante l’autopsia, rilevare l’altissimo tasso alcolico nel sangue di un calciatore notoriamente astemio. Poi tutto divenne nero.
La dissolvenza aveva lambito quelle due vite che solo per un attimo si erano trovate, incrociate, vissute e disintegrate. Com’è fatidico, a volte, il destino.
Stefania cercava Ivan al telefono, che ora non dava più segni di vita. Che figlio di puttana! Chissà con chi era, cosa faceva o pensava quel grande stronzo di suo marito.
Elvis saettò accanto alla mamma, gli volò tra le braccia e le diede un bacio con lo schiocco.
Stefania prese lo strano pacchetto pesante e incartato con il suo foulard di Gucci che il cane aveva finalmente finito di riportare dall’oblio. Ritentò la chiamata e aprì distrattamente l’involucro plastificato e pieno di terra.
Michele raccolse con calma tutte le sue cose e con la flemma di chi è in vacanza se ne tornò a casa in macchina senza superare i limiti e rischiare di essere fermato da qualche pattuglia. Fischiettava felice e un po’ sudaticcio, appena arrivato avrebbe fatto una doccia e inventato una scusa per il rientro anticipato. Alla radio adesso qualcuno doveva accendere il fuoco di Jim Morrison, ma a Michele non importava affatto perché il suo, di fuoco, era vivo e prepotente.
La deflagrazione non lasciò molto né di Elvis ne di sua madre.
La bomba li devastò lasciandoli nella beata ignoranza della vita che finiva senza sapere perché.
Il pacco era stato interrato da Ivan nella mattinata sperando che Ideafix riesumasse come sempre quello che vedeva sotterrare. Sperava che il cane becchino svolgesse il suo compito.
Aveva concepito il piano leggendo i romanzi di Sherlock Holmes e Agatha Christie. Sperava che il piano pazzesco andasse in porto perché non poteva sopportare che la sua Fiaba Dorata si frantumasse contro quelle foto sadiche e perverse. Non voleva che il suo hobby dopolavoristico venisse fuori. Michele aveva iniziato a essere pericoloso e aveva minacciato di dire tutto a Stefania, Ivan non avrebbe permesso a nessuno di rovinare la sua architettura perfetta.
Se la bomba non fosse esplosa ci avrebbe pensato il cianuro. Ma il destino è burlone e a volte sta dalla tua parte nei momenti del bisogno.
Anna, passando in automobile vide il fuoco che si alzava dalla casa, lingue rosse alte fino al cielo e pensò che forse un bambino avesse giocato un po’ troppo pesante col fuoco. Poi si rese conto che era la casa di Ivan e forse quel pestifero del figlio ne aveva combinata una delle sue. Una di quelle grosse. Si, a volte i bambini scherzano col fuoco, ma poi muoiono.
Nell’autoradio intanto il Re Lucertola diceva alla sua piccola di accendere il suo fuoco.
Michele non fece nemmeno in tempo a rendersi conto di essere arrivato a casa che fu circondato da una quantità infinita di poliziotti, carabinieri, cani molecolari, giornalisti e giornalai. Si chiuse dentro il SUV appena in tempo. Sentiva la voce del maresciallo Turra che gli intimava di scendere con le mani in alto senza fare tante cerimonie; il vetro oscurato lo celava alla vista di quel pubblico curioso e metodico e quindi non potevano vedere che stava ridendo con malcelato disprezzo verso di loro. Sentiva ancora l’adrenalina scorrere come lava incandescente in tutto il corpo. Il tramonto rosso sangue di Hollywood è perfetto, pensò Michele.
Prese la Glock carica dalla borsa e chiuse la bocca strettamente attorno alla canna. Gli venne in mente il membro di Ivan e una sacrosanta erezione lo colse impreparato. Che cosa disdicevole morire con l’uccello in tiro. La nonna ne sarebbe stata disgustata. Non sentì le grida provenienti dall’esterno e non seppe mai che i vigili del fuoco gli avevano distrutto la portiera con la pinza idraulica. Nemmeno che l’autopsia mise in luce che era affetto da sifilide e HIV. Frammenti di quel cervello maligno erano sparsi su tutto il cielo personalizzato in alcantara color fragola della macchina. Quella storia era finita ancor prima di iniziare e il maresciallo sentiva che un feroce mal di testa lo avrebbe tormentato tutta la notte.
Nel frattempo, sulla piazza del paese, la Via Crucis mormorando si fermava sotto la stazione del Golgotha. Il prete pregava con le vecchie e i chierichetti. Gesù era ormai arrivato alla fine.
Come in un film muto, il cielo virava dal rosso al blu. Peccatori di ogni sorta affollavano il bar alla moda poco lontano dal cammino doloroso dei penitenti.
La ragazzina ormai era andata via chissà dove: forse verso il nulla o alla prossima fermata per l’inferno. Gioia piangeva chiusa in camera da letto, sola come sempre mentre il dolce Maritino le preparava la cena prima di recarsi al calcetto e poi dalla sua giovane amante diciannovenne.
Due signore davanti al fioraio spettegolavano sulla tabaccaia nuova, un po’ troppo prosperosa e il barista, ormai pieno, svuotava la vescica nel retro del deposito.
La primavera nell’aria incendiava il futuro e le voglie di tutti: di lì a poco la pelle avrebbe tirato per il troppo sole e anche altro avrebbe teso la stoffa dei vestiti troppo leggeri.
Tutto quel desiderare è di Bologna stessa: così ingorda e fantastica come nulla al mondo. Il desiderio e la voglia di vivere a mille, senza morire mai, senza pensare a domani perché domani era ieri; pensare che domani potrebbe essere un altro giorno, ma ci avremmo pensato poi domani.
Il cielo ormai sanguinante piegava verso la notte tiepida e bellissima di Maggio, eccitante come solo a Bologna sa essere; verso quel desiderio caldo che avrebbe pervaso la notte, mentre il Re Lucertola alla radio chiamava la sua ragazza ad accendere il suo Fuoco.
Domani è un altro giorno, almeno così la gente spera. Domani Dio sarà ancora morto.
Almeno un altro giorno ancora.
Categorie: Libraio, Racconti, Scrittoio
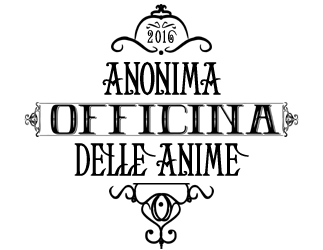



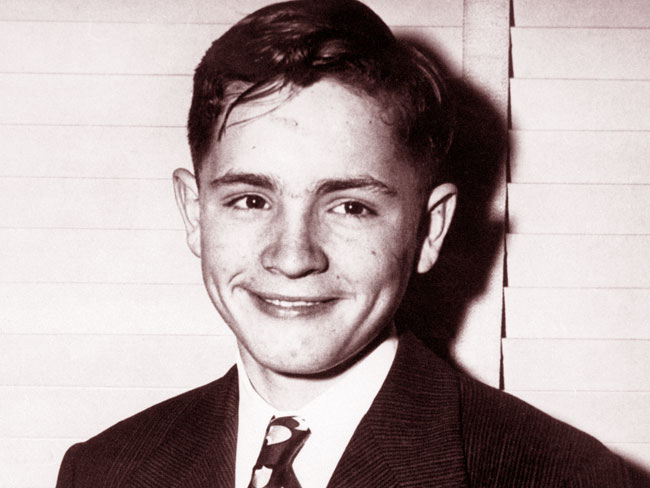
Mio Dio (che è risorto!)… ma sei un mito!!!
A quando un libro?
Avvisami e… voglio una super dedica!
Brava!
Ciao tesoroooooo…… Grazie!!!!!! Non ti preoccupare, sarai la primissima!!!! Grazie ancora…. Un bacione grande